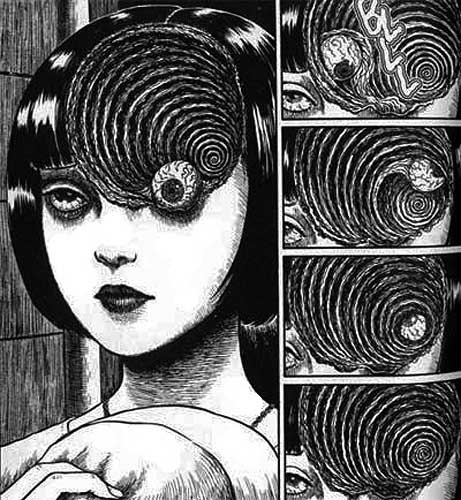Dal 2020 in poi alcuni aspetti della mi vita sono molto cambiati, e il più importante di essi è il mio rapporto con la mia bolla. Il 2020 è stato l’anno segnato dalla pandemia di COVID-19 e dall’esplosione della bomba del politicamente corretto, due questioni su cui mi sono trovato sul lato opposto a un po’ tutta la cultura di centro sinistra che sembra rappresentare la maggioranza dei miei lettori.

Senza perderci per ora sulle questioni collegate al coronavirus, andiamo sul fronte del politicamente corretto, e in particolare sulla più grande cagat… pardon, intendevo, sulla questione più importante, centrale e controversa che è stata sollevata da sinistra ultimamente. E ovviamente non sto parlando di razzismo sistemico, diritti riproduttivi, violenza sulle donne, ma della declinazione femminile dei mestieri.
Il caso ritorna periodicamente alla ribalta ma in questo periodo peggio del solito, testimonianza imperitura di quanto durante il lockdown godiamo di troppo tempo libero, e recentemente il pretesto che ha riportato l’attenzione su di esso sono state le dichiarazioni di Beatrice Venezi, direttore dell’orchestra dell’Ariston, che ha dichiarato la preferenza per il titolo “direttore d’orchestra”, declinato al maschile non marcato, sul femminile “direttrice d’orchestra”.
Apriti cielo.
La poveretta non immaginava la gravità delle sue affermazioni, esternazioni ai limiti del nazismo che con poche parole hanno cancellato secoli di diritti delle donne, avallato femminicidio e burqa, peggiorato significativamente il riscaldamento globale e fatto piangere Gesù.
Riuscite a immaginare un tema più fondamentale su cui un progressista potrebbe decidere di concentrarsi? Letteralmente impossibile, suppongo.
Ora, sarebbe molto facile dire in questo caso che i problemi sono ben altri, ma verrei accusato di “benaltrismo”.
Il che mi permette di fare la prima importante precisazione a riguardo: asserire o implicare che certi problemi meno seri non debbano essere trattati affatto, nel nome del fatto che ce ne siano altri più seri, è un ragionamento chiaramente fallace: quello che chiamiamo “benaltrismo”, appunto. Questo però non significa che sia sbagliato in generale stabilire una gerarchia di rilevanza dei problemi e, sulla base di questa, assegnare delle priorità e stabilire una proporzione di risorse da dedicare alla questione. Che un discorso su come si declina al femminile una parola possa occupare i giornali per giorni rappresenta chiaramente un caso in cui il senso delle priorità nei discorsi e nei problemi va perduto, così come in generale la stessa tendenza è espressa da tutti i commenti indignati di femministi e femministe che trattano Beatrice Venezi come una specie di traditrice maxima colpevole di tutti i mali della terra. Rilassiamoci, tesori, “direttore” è UNA CAZZO DI PAROLA, non un omicidio.
Ma a parte questo, insistere sul fatto che i problemi siano ben altri, qui, sarebbe comunque ipocrita da parte mia, perché io non penso che le declinazioni femminili dei nomi siano un problema piccolo o di scarsa importanza: io penso che NON SIANO un problema, e che la proporzione delle risorse politiche e dell’attenzione pubblica da rivolgervi dovrebbe essere non “poco”, ma precisamente zero. E se mentre di suo il problema in sé è un non-problema, è un problema il fatto che il non-problema diventi un problema, non so se mi spiego. Ed è su questo ultimo aspetto che mi sento obbligato a intervenire.
Ma prima di procedere con l’esposizione della mia opinione a riguardo, occorre levare di torno alcune formalità. La prima di esse è: cosa dice la grammatica a riguardo?
STAR WORDS EPISODE I: THE GRAMMATICAL MENACE
Ora, alcune discussioni sui social mi hanno fatto scoprire che a questo riguardo, nelle bolle ideologiche “di sinistra”, si è sviluppata la credenza che usare il maschile per professioni svolte da donne sia sbagliato, e sia obbligatorio invece utilizzare il femminile. La Venezi, quindi, non avrebbe soltanto annientato secoli di lotte per l’emancipazione femminile, ma commesso anche un errore grammaticale. Il Lato Oscuro è potente in questa donna.
Questo sarebbe un interessante caso di studio su come si crea e moltiplica una credenza completamente infondata in comunità all’interno delle quali nessuno ti contraddice. Perché niente di tutto ciò corrisponde a vero. Ora dovrò dire delle cose che dopo averle dette sembreranno banalità, ma evidentemente è necessario ripeterle.
La prima cosa da fare è enunciare un principio generale su cosa significhi “grammaticalmente corretto”. La grammatica è un insieme di regole formali che ordinano il nostro linguaggio rendendolo comprensibile a tutti i parlanti. Poiché il principio centrale di funzionamento di ogni lingua è l’intendersi a vicenda, in realtà risulta corretto tutto quello il cui uso diventa abbastanza esteso e radicato da essere inteso da tutti con la medesima agevolezza e senza storcimenti il naso. Quindi, a priori, qualsiasi forma può essere corretta, se tutti la usano. Un caso particolarmente tragico che spesso cito a riguardo è la dicitura “il/un pneumatico”. Ragazzi, ma come cazzo fate a pronunciare un obbrobrio simile? È oggettivamente cacofonico perché obbliga a inanellare una “n” e poi una “p” e poi un’altra “n” senza nessuna vocale di mezzo, sembra il nome di un alieno. Eppure, vi garantisco che word non lo corregge, e la Crusca lo ha dichiarato accettabile, pur indicando la forma “lo/uno pneumatico” come più adeguata ad un registro formale. Questo perché è una questione di uso, e se lo usano tutti, raga’, sembra che mi toccherà sopportarlo.
E la Crusca, quando è chiamata a giudicare sulla correttezza di una forma o di un’altra, alla fin fine applica un primo metro che è di correttezza “formale”, ovvero se il costrutto sia coerente con norme sedimentate nella nostra lingua, e poi va a valutare se l’espressione contesa sia utilizzata e diffusa a sufficienza da potersi ritenere “corretta”.
Riguardo alla questione dei femminili dei nomi di mestiere la Crusca è intervenuta esclusivamente per dire che essi sono in generale “ben formati”, ovvero la loro formazione è compatibile con i principi noti della grammatica. Dunque, queste forme sono ammissibili.
Non ha però MAI detto che siano obbligatorie, necessarie, che non usarle sia un errore. MAI. E il presidente della Crusca, Marazzini, è intervenuto sulla questione posta da Beatrice Venezi per asserire che se “direttrice” sarebbe stato corretto, lo è anche “direttore”. Marazzini ha anche specificato che l’uso in questione si chiama maschile inclusivo, o maschile non marcato, che potremmo definire un uso del maschile in senso neutro.
Nella mia bolla ideologica si è diffusa di fronte a questa asserzione una risposta automatica, tipo quelle che metti nella mail: “MA IN ITALIANO NON ESISTE IL GENERE NEUTROOOO!”
Wow. Geniale. Tutti quanti esperti di linguistica. Ci vuole davvero una mente superiore per accorgersi che in italiano non c’è il genere neutro. Probabilmente questo sta in cima al podio degli argomenti più capziosi che abbia mai udito nella mia vita: ovvio che non c’è il genere grammaticale neutro in Italiano, ma in italiano, come in tutte le lingue, esiste un uso neutro dei termini. Non si può sempre specificare il genere sessuale di persone o animali; se io per strada ho visto un lupo non ho modo di sapere se sia maschio o femmina, quindi mi serve una forma che abbia un significato neutro rispetto alla questione. Poiché come molti argutamente notano in italiano il genere neutro non esiste, quel ruolo lo svolge il genere maschile, dunque “ho visto un lupo”, e non “ho visto una lupa” e nemmeno facezie tipo “ho visto un* lup*”.
Questo uso si chiama “maschile non marcato”: il genere grammaticale è maschile, ma include come significato tanto il maschile che il femminile. Quindi per neutralizzare i vari sofisti che ti inchiodano se ti permetti di dire che in Italiano c’è il maschile neutro, con un colpo di mano io dirò sempre “maschile non marcato”, facendo così esplodere come una scorreggia la loro potente retorica.
Chiaramente a decretare se il maschile non marcato sia corretto o meno o se sia preferibile o meno alle forme declinate sarà l’uso, ma è chiaro che in questo momento l’uso o il non uso non è ancora sedimentato in modo tanto preponderante da giustificare chi, da un lato o dall’altro del dibattito, voglia accusare il prossimo di star commettendo strafalcioni linguistici.
Dunque dire che la Venezi è “direttore d’orchestra” è corretto, grammaticalmente. Ma questo non la scagiona dal crimine ben più grave di cui la si accusa: ella ha letteralmente annientato secoli di lotte femministe.
Ma come ha fatto? Donde proviene questo straordinario potere?
Lo scopriamo subito.
STAR WORDS EPISODE II: ATTACK OF THE GENDERS
Tutto inizia, in Italia almeno, con un libro vecchio esattamente quanto me; “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua” di Alma Sabatini.
Prevedibilmente l’origine di questo filone è fuori dall’Italia e come al solito gli italiani sono andati a copiare mode straniere anche in questo, ma in sostanza il saggio in questione è una lunghissima masturbazione intellettuale dell’autrice che è andata a spulciarsi Dio sa quanti giornali e annunci di lavoro per catalogarne uno per uno tutti gli usi del maschile non marcato o sovraesteso e dire “questo è il male”.
Non mentirò dicendo di essermi sottoposto alla tortura di leggermelo tutto, perché onestamente non rientra nei limiti della mia umana sopportazione riuscire a sottopormi ad uno sfracellamento di palle così esteso e approfondito. E non sarebbe servito, perché la questione che interessa a me quel testo non la tratta. Ho letto l’introduzione e scoperto che la Sabatini parlava di come la lingua influenza la realtà e il nostro pensiero, di quanto questa idea sia accettata da Tutti i Linguisti® (gli stessi Tutti i Linguisti® che pensavano che il maschile non marcato fosse sbagliato, ipotizzo) ma non pare si prenda il disturbo di fornire referenze che giustifichino questo argomento. Peccato che sia… come dire… IL FULCRO DI TUTTO IL DISCORSO?
Quella tesi del “linguaggio che influenza la realtà” l’ho sentita ripetere ad nauseam in questi giorni, ma nessuno me l’ha mai giustificata con dei dati. Il ragionamento che c’è dietro sembra essere che l’uso del maschile non marcato in qualche modo “invisibilizza le donne”, e poiché “il linguaggio plasma la realtà” – e altri luoghi comuni pseudofilosofici che non significano un cazzo di niente – questo in qualche modo propaga ed alimenta la sottomissione delle donne.
Come lo fa? Perché? In che modo si suppone che agisca?
Domande che uno in questi casi tenderebbe a porsi, ma cui nessuno perde troppo tempo a rispondere. A rigor di logica, è impossibile vedere un modo in cui un uso linguistico come il maschile universale possa influenzare la realtà in qualunque maniera. Come dicevo sopra, il maschile inclusivo è una convenzione linguistica, e in quanto tale si basa sulla comune intesa del suo significato, e il genere grammaticale stesso in generale è una convenzione: va da sé che una -a o una -o alla fine di una parola non abbiano alcuna implicazione sociale se non quella che vogliamo attribuirvi. Se è per questo, in italiano “il contralto” e “il soprano” sono termini di genere maschile, eppure contralti e soprani sono tutti femmine; in che modo questa nozione dovrebbe “plasmare la realtà” o alterare il pensiero o altre facezie di questo genere? Sono solo sequenze di suoni, mica evocano demoni. Se noi ci intendiamo che un contralto è una femmina quale altro effetto potrebbe mai avere quell’uso linguistico sulla nostra psiche?
Difficile rispondere ad un argomento che nessuno ha portato, a dei dati che nessuno ha prodotto, ad un’idea che nessuno ha supportato. Mi sono andato a cercare dei dati su questa presunta influenza del maschile inclusivo sulla psiche delle persone, e non ne ho trovati. Ho chiesto a chi conduceva questa crociata di portarmeli lui, ma nessuno lo ha fatto. Vi prego, lettori miei, se avete qualche dato che indichi 1) la correlazione fra maschile inclusivo e atteggiamenti sessisti e anche 2) il rapporto di causalità del primo verso i secondi, linkatemelo qui sotto. VOGLIO leggere questo lavoro rivoluzionario.
Anche perché sarebbe interessante capire COME CAZZO POSSA FUNZIONARE UNA COSA DEL GENERE. Perché onestamente, non si riesce a ipotizzare una plausibilità o un meccanismo di azione per questo presunto effetto. Normalmente il linguaggio è il sistema che permette di intendersi associando segni a idee: se io vado in Giappone, fermo qualcuno per strada e gli dico con un bel sorriso “sei un figlio di puttana” e poi me ne vado, quello, che non sa l’italiano, resterà un po’ perplesso, cercherà di indovinare cosa potessi voler dire, e non registrerà minimamente l’insulto. Questo perché non ha uno schema di significati da calarvi sopra e che gli permetta di trarne un senso. Non c’è l’intesa fra me e lui secondo la quale “figlio di puttana” è un insulto molto volgare. Questo meccanismo del quadro comune di significato è alla base dell’intendersi e dunque del linguaggio, è sulla base dell’intesa che il linguaggio esercita l’effetto. Non sulla base dei suoni, non sulla base degli intenti, non sulla base dell’etimo. Sull’intesa, solo quella.
Ora, sicuramente le parole plasmano i comportamenti delle persone, questo è così lapalissiano da non necessitare nemmeno di dati a supporto… ma lo fanno attraverso uno schema di significati. La parola evoca il suo significato nella mente dell’altro, è così che lo influenza. “Figlio di puttana” è un insulto se entrambi lo intendiamo come tale, ovverosia solo se io voglio usarlo come insulto e il mio interlocutore lo vede anch’egli come un insulto.
Ma con il maschile inclusivo lo schema di significato dice che quel maschile grammaticale ha un significato neutro, che comprende tanto il maschile che il femminile; non c’è nessuna “invisibilizzazione” o negazione delle donne, sono comprese nel significato. Rispetto al significato, l’unica differenza fra “direttrice d’orchestra” e “direttore d’orchestra” è che nel primo caso voglio specificare che la Venezi è una donna, e nel secondo invece potrebbe essere sia donna che maschio. Quindi questo crea un uso differenziale nel momento in cui io voglia dire, per esempio, “è la migliore direttrice d’orchestra del mondo” che avrà un senso diverso da “è il miglior direttore d’orchestra del mondo”: nel primo ci limitiamo ai direttori donna, nel secondo a tutti. E se invece volessimo dire che un uomo è il miglior direttore d’orchestra, ma limitatamente agli uomini? Allora dovremmo dire “è il miglior direttore d’orchestra uomo”.
Caspita, molto razzista nei confronti degli uomini dover aggiungere quella parola per specificare che parliamo dei maschi, vero…?
No, non è vero. Stiamo solo cercando di trasmettere significato e di capirci, non ci sono chissà quali malignità dietro. La Venezi preferisce enunciare il proprio ruolo senza accentuare il proprio sesso, ma ciò non significa che stia dicendo di essere uomo, o che solo gli uomini possono avere quel ruolo, o che non esistano direttrici d’orchestra donne (seriously? Ma come si fa a pensare un’idiozia simile?). Semplicemente affida alla regola grammaticale del maschile inclusivo l’intesa che potrebbe essere sia maschio che femmina.
Quindi sul piano del significato stiamo parlano letteralmente del nulla: “direttore” o “direttrice” differiscono esclusivamente per una sfumatura di enfasi sulla forma dei genitali della persona. “Il direttore d’orchestra” vuol dire “la persona che dirige l’orchestra”, maschio o femmina che sia. Fine.
Quindi, quale che sia l’influenza che si attribuisce a questo linguaggio capace di “plasmare la realtà”, la cosa strana è che questa influenza prescinde dal significato. Ovvero prescinde dalla funzione stessa svolta dal linguaggio, che è quella di intendersi.
Sì, il maschine inclusivo significa “neutro”, è il suo modo di funzionamento. Eppure, si dice, anche così in qualche modo avrebbe il potere di negare la femminilità. Viene attribuito qui, alla parola, un potere che trascende il suo senso, il modo in cui viene intesa. Vi è in essa un qualcosa di più, un aspetto ineffabile e sottile, subconscio, pervasivo ma impercettibile al tempo stesso.
Uhm.
Una filosofia del linguaggio in cui le parole hanno valore indipendentemente da come le intende chi le ascolta…
Dov’è che abbiamo già visto una cosa del genere?
STAR WORDS EPISODE III: REVENGE OF THE CAZZARIS
Oh, sì, scrissi fiumi di inchiostro per criticare la filosofia del linguaggio di Gualtiero Cannarsi, in un mio articolo che riscosse un discreto successo.
Forse me la giocavo troppo facile: dopotutto il lavoro di Cannarsi è evidentemente disastroso, quindi andare a spiegare quali sono i vizi filosofici che stanno dietro a quel disastro è semplicemente un esplicitare qualcosa che il lettore già sa e con cui concorda.
Non altrettanto immediato, però, è riuscire a capire nel profondo l’estensione e il significato dei vizi filosofici di Cannarsi, e quindi vedere gli stessi vizi se vengono applicati in altri ambiti, magari in modo meno plateale, più subdolo.
Il mio suggerimento è di andare a leggere l’articolo su Cannarsi prima di andare avanti, se non l’aveste già fatto; ma se non volete vi faccio un breve riassunto delle puntate precedenti: Cannarsi è un adattatore che presta la propria fenomenale competenza per gli adattamenti in italiano degli anime dello Studio Ghibli. Più che famoso è famigerato perché i suoi adattamenti sono caratterizzati da una strana e macchinosa traduzione letteralista: Cannarsi non tenta di tradurre il giapponese nella forma italiana che meglio ne riproduce il senso, bensì in quella che meglio ne riproduce la lettera (qualche esempio). I risultati sono quelli che si possono immaginare: non puoi riprodurre strutture sintattiche e costrutti specifici di una lingua alla lettera in un’altra lingua, ne esce fuori una roba che è incomprensibile nella lingua d’arrivo. Difatti, questo è quello che fanno i programmi di traduzione come Google Translate: prendono le parole e cercano la parola corrispondente in Italiano, perché non hanno la capacità di capire il senso e non sanno renderlo. Non cambiano l’ordine delle parole, non cercano il termine che renda meglio l’intento comunicativo dell’originale, non si sforzano di riprodurre le stesse impressioni e in generale gli stessi significati. E Cannarsi fa la stessa cosa, in un certo senso egli traduce cercando di non tradurre, traduce senza occuparsi di rendere bene il senso; egli sembra considerare la traduzione automatica fatta dai programmi appositi una specie di ideale regolativo.
La filosofia del linguaggio di Cannarsi, che nell’altro articolo paragonavo a quella dei letteralisti biblici, sarebbe quella secondo cui in un testo, in una sequenza di parole, il nucleo che conta di più non sia il significato, bensì un universo di rimandi e relazioni esterne fra le parole stesse, che sta nel loro ordine, nel loro suono, nella loro lunghezza e frequenza.
Ora, non è che i rimandi, le allusioni, gli echi, la storia e l’etimo di una parola non siano utili nella composizione o traduzione di un testo. Figurarsi. Sono importanti alla luce di quanto possono precisare e delineare meglio sfumature di senso… ma non fino a mettere in parentesi il senso, non fino a mettere il senso in disparte o perfino oscurarlo. Gli orrori linguistici di un ragionamento secondo cui nell’analisi del linguaggio si può accantonare il problema di cosa esso trasmetta, di cosa esso significhi, in favore di una fantomatica riverenza nei confronti della sua forma, sono autoevidenti: perdi il senso, scrivi cose che non significano niente.
E questo modus cogitandi cannarsiano è lo stesso che sta dietro tutte queste epiche battaglie contro il sessismo nella lingua. “Direttore d’orchestra” al maschile ha un significato neutro, è questo che significa e non c’è molto dibattito possibile a riguardo (specie se a usarlo in quel modo è proprio una donna che dirige l’orchestra, quindi non vi sono possibili ambiguità). Ma alcuni non sono contenti di ciò che significa, non gli basta, e vanno ad immaginare che quella forma possa rimandare ad altro: si guardano la storia, la sequenza dei suoni, l’etimo – generalmente in modo molto superficiale, peraltro – e iniziano a fare ipotesi sul perché e sul percome si usi un maschile grammaticale… e in tutta questa analisi viene però completamente cancellato il significato, e cioè quello di un’espressione che è neutra rispetto al genere.
Esattamente come Cannarsi si maschera da grande cultore di lingua e cultura giapponese e traveste i suoi pastrocchi da raffinati esercizi intellettuali, le riflessioni insistite ed ossessive sul genere grammaticale diventano anch’esse grandissime masturbazioni intellettuali che superficialmente paiono complesse e argute, ma di fatto non hanno alcun contatto con la realtà. Semplicemente, mentre a Cannarsi non riesce bene di farsi passare per genio e cultore della lingua, ai cazzari che impostano epiche battaglie per le sorti dell’umanità su di una convenzione grammaticale questa recita riesce un po’ meglio. Ma non vi sono differenze filosofiche: dietro la mascherata di grande avanzamento scientifico e sociale si nasconde una profonda regressione culturale che riconduce il pensiero ad uno stadio pre-linguistico, una condizione in cui segni e simboli non possono più essere compresi in quanto significanti, ma diventano formule magiche e riti.
Perché in effetti che cos’è la frase “il linguaggio plasma la realtà”, se non una dichiarazione di fede nella magia? La convinzione che segni e suoi influenzino la struttura della natura è alla base del pensiero magico primitivo. Questo non è progresso sociale, politico, scientifico. Molto banalmente, si chiama superstizione.
Conclusioni
E qui si ritorna all’inizio, quando dicevo che i problemi sono ben altri, e c’è chi molto a luogo fa notare che i problemi sono ben altri, ma nel frattempo su questo problema ho scritto sei pagine di word.
Ma d’altro canto, perché in passato ho scritto tanto anche su Cannarsi, quando a me gli anime dello Studio Ghibli manco piacciono particolarmente?
Perché se è vero che la desinenza di un sostantivo non cambia di una virgola la vita di nessuna donna o uomo della terra, e in questo senso si potrebbe semplicemente ignorarla, quello che non si può ignorare è il deterioramento filosofico che questa battaglia porta con sé. Di fatto, quando un dibattito del genere si impone sul pubblico, questo è sintomo di un generale abbrutimento intellettuale, di una perdita del contatto proprio con la lingua, con le sue funzioni, potenzialità e scopi, e in generale di un’involuzione delle nostre capacità di pensiero astratto.
Non ultimo, piantare grane epiche su queste sciocchezze ha tutta una serie di effetti collaterali pericolosi: si vanno a creare divisioni e conflitti politici gravi sulla base di temi di infima importanza, si fornisce agli estremisti un pretesto per incancrenirsi ulteriormente nelle proprie posizioni, e ci si aliena gli alleati. Personalmente, sono stato attaccato ed insultato per le mie opinioni abbastanza da alienarmi per sempre le simpatie di qualsiasi causa femminista, anche quelle che condivido, perché non ho intenzione di trovarmi affiliato o nella stessa squadra con dei nazisti linguistici pronti a darmi di fascio sulla base di una -a o di una -o alla fine di una parola.
In buona sintesi, queste battaglie linguistiche sono in primis inutili, in secondo luogo sono spesso semplicemente sbagliate (come quando si afferma erroneamente che il maschile non marcato sia scorretto), successivamente hanno presupposti filosofici viziati, e come se non bastasse scatenano conflitti che però possono avere conseguenze, queste sì, serie.
Con un rapporto costi-benefici così disastrosamente sbilanciato dalla parte del danno una persona intelligente una battaglia così la abbandonerebbe subito, o quanto meno ne smorzerebbe TANTO i toni.
Non che di persone intelligenti il mondo sia prodigo, purtroppo.
Ossequi.
E anche ossequie, dai, se no invisibilizziamo le donne.